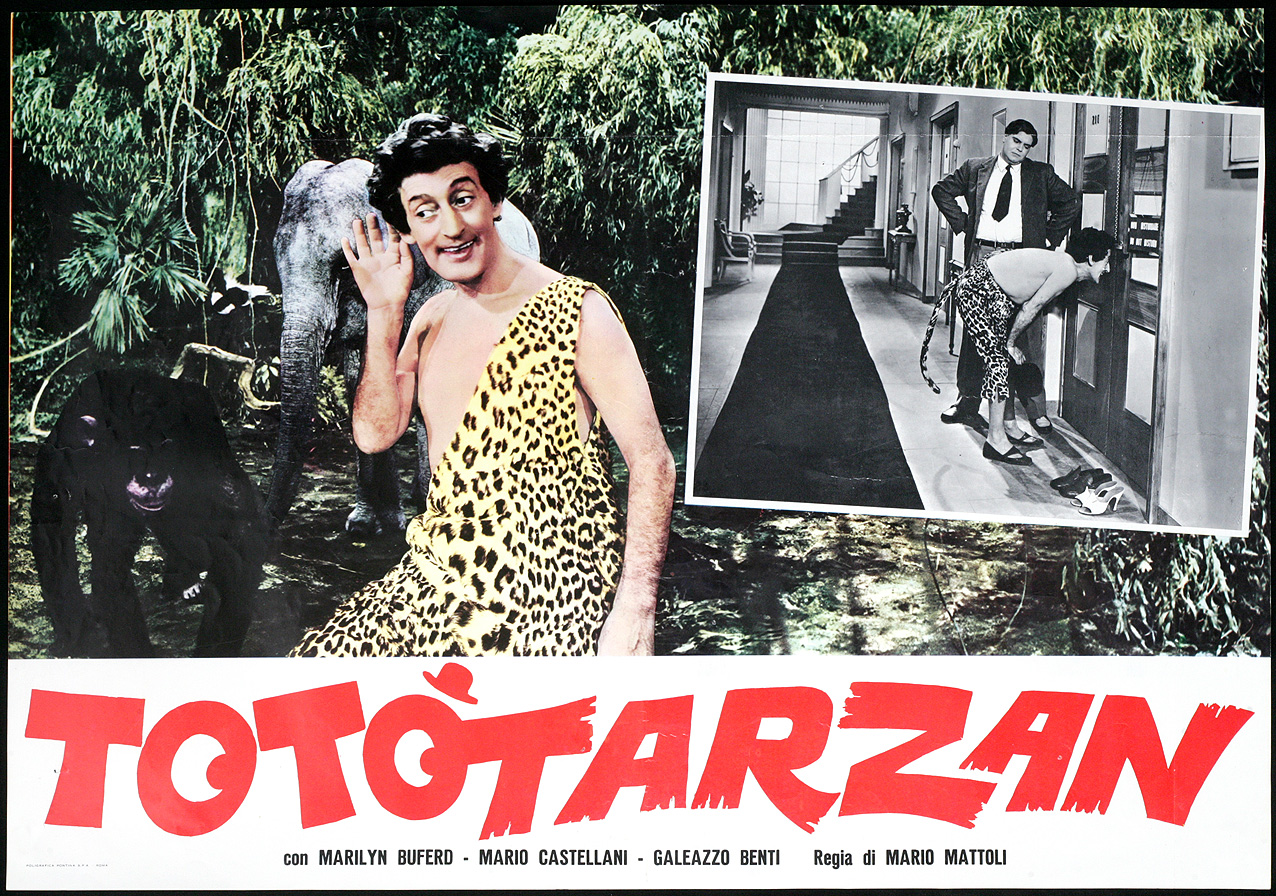Capitolo 2.1 (parte 14) I musicisti cinematografici del dopoguerra: i “maggiori”, fra tradizione ed innovazione
Il Mulino del Po (’49) di Alberto Lattuada; musica di Ildebrando Pizzetti
Quando Berta torna al Mulino, sentiamo gli archi confermarci, con quella stessa melodia, che esso è il simbolo del fiume e di quei pochi contadini che, lavorandoci, sopravvivono alla miseria, senza dover cedere allo sfruttamento di un padrone. Ma anche il Mulino ha un padrone, il Re d’Italia Umberto I che manda la finanza a controllare i giri delle pale e quindi a tassarlo di conseguenza (è la tassa sul macinato).
Sul Mulino si sta svolgendo il fidanzamento tra Berta e Orbino (Jaques Sernas). Mentre le due famiglie parlano del corredo, Orbino dà alla sua amata due colombi in segno d’amore. Sono tutti e due felicissimi e bramano di sposarsi al più presto. Una barca di pescatori passa e saluta Cecilia (Isabella Riva), padrona del Mulino e madre di Berta, augurando felicità ai fidanzati. La situazione, estremamente di schietta e semplice cordialità, è coronata da un canto corale che si ode nelle vicinanze. Probabilmente si tratta di una cantata popolare dei pescatori della Val Padana che lega ancora di più tutti quegli uomini, poveri, ma felici nel loro duro lavoro, e li contrappone a quelli che giungono poco dopo, la finanza di Sua Maestà il Re, visti come emissari e simboli della macchina impietosa e sfruttatrice del governo.
E’ notte e Princivalle (Giacomo Giuradei), fratello di Berta, viene traghettato da Raibolini sulla riva: egli deve procurargli una donna, come è solito fare, in cambio di un sacco di farina. Dei barcaioli stanno intorno al fuoco, ad ascoltare un sindacalista che gli parla di rivoluzione proletaria contro il capitalismo borghese e di creare una lega, spargendo la parola rivoluzionaria anche ai contadini dei campi intorno. Ma Princivalle non se ne cura affatto, ché lui è mugnaio e non deve rendere conto a nessuno del suo lavoro. Il sindacalista, allora, lo minaccia e così anche gli altri, i quali lo avvertono di stare attento alla finanza, se non farà parte della “Lega”. Il suo interesse va ad una donna (una sorta di zingara?) che appartiene, però, a Raibolini che lo avverte di non guardarla nemmeno.
 Tutta la scena è accompagnata da una musica che quasi ricorda una danza macabra. Si tratta di una habanera, una danza cubana di origine spagnola, in ritmo binario, diffusa soprattutto nell’ottocento nell’America latina. Molti compositori europei hanno scritto habanere, le più celebri sono quelle di Bizet, Debussy e Ravel. Questa danza vuole informarci del nefasto desiderio nascente del mugnaio per quella donna che sarà, lo vedremo più avanti, causa scatenante di tutti i mali e le tragedie che colpiranno la famiglia Scacerni. Ricorda, infatti, la danza della gitana nella Carmen di Bizet, un rito propiziatorio capace di ammaliare e condurre la vittima su di una strada tragica. Essa serve a staccare ancora di più Princivalle dal contesto “politico” in cui dovrebbe essere immerso, assolutizzandolo nella sua insana bramosia. Dopo la messa in paese, ecco il comizio del sindacalista che spiega a tutti i contadini l’importanza di costituirsi in Lega. Princivalle se la ride e va ad appartarsi con la zingara. Comincia, allora, a soffiare un vento forte, quasi fosse un avvertimento di Dio, che fa chiudere il comizio. Raibolini coglie i due amanti uno avvinghiato all’altra e viene deriso e scacciato dalla donna, mentre il mugnaio ride. Prima di allontanarsi, però, egli grida vendetta contro il mugnaio e sarà una vera tragedia. Intanto, il vento soffia ancora più rabbiosamente, provocando la piena del Po. Non c’è tempo da perdere per la famiglia Scacerni, devono salvare le pale del Mulino dalle frasche e dagli arbusti trascinati dalla forte corrente; ma Princivalle ancora non si vede, lui che è il più esperto e il più forte in una lavoro del genere.
Tutta la scena è accompagnata da una musica che quasi ricorda una danza macabra. Si tratta di una habanera, una danza cubana di origine spagnola, in ritmo binario, diffusa soprattutto nell’ottocento nell’America latina. Molti compositori europei hanno scritto habanere, le più celebri sono quelle di Bizet, Debussy e Ravel. Questa danza vuole informarci del nefasto desiderio nascente del mugnaio per quella donna che sarà, lo vedremo più avanti, causa scatenante di tutti i mali e le tragedie che colpiranno la famiglia Scacerni. Ricorda, infatti, la danza della gitana nella Carmen di Bizet, un rito propiziatorio capace di ammaliare e condurre la vittima su di una strada tragica. Essa serve a staccare ancora di più Princivalle dal contesto “politico” in cui dovrebbe essere immerso, assolutizzandolo nella sua insana bramosia. Dopo la messa in paese, ecco il comizio del sindacalista che spiega a tutti i contadini l’importanza di costituirsi in Lega. Princivalle se la ride e va ad appartarsi con la zingara. Comincia, allora, a soffiare un vento forte, quasi fosse un avvertimento di Dio, che fa chiudere il comizio. Raibolini coglie i due amanti uno avvinghiato all’altra e viene deriso e scacciato dalla donna, mentre il mugnaio ride. Prima di allontanarsi, però, egli grida vendetta contro il mugnaio e sarà una vera tragedia. Intanto, il vento soffia ancora più rabbiosamente, provocando la piena del Po. Non c’è tempo da perdere per la famiglia Scacerni, devono salvare le pale del Mulino dalle frasche e dagli arbusti trascinati dalla forte corrente; ma Princivalle ancora non si vede, lui che è il più esperto e il più forte in una lavoro del genere.
La musica che accompagna tali immagini è fortemente descrittiva, tesa alla ricreazione di quello che le immagini già mostrano potentemente. Il soffiare violento del vento è reso da rapidissime quartine di semicrome degli archi, con gli ottoni squillanti che punteggiano gli interventi degli uomini. Quando compare sulla scena Princivalle, ecco che gli ottoni squillano ancora più forte, a significare l’intervento di un uomo istintivo come la Natura, solo capace di domarne i caratteri più catastrofici e distruttivi. Quegli ottoni e quegli archi sembrano rievocare un’antica e gloriosa battaglia, quella dell’uomo contro la Natura, allo stesso tempo madre e matrigna dei contadini.